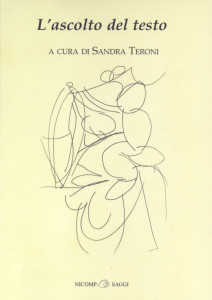Arte come riparazione: Artemisia Gentileschi e Marianna Ucria
Marianna
La protagonista del bel libro di Dacia Maraini, La lunga vita di Marianna Ucria, è un personaggio realmente esistito. Antenata della scrittrice, subisce in tenera età uno stupro da parte di uno zio materno, tenuto segreto da tutta la famiglia.
Fu una violazione così violenta da rendere sordo e muto l’intero corpo.
“Una cosa di uomini fu.”
“Un segreto di uomini che neanche la Signora sapeva.”
Sapeva o non sapeva la Signora madre di Marianna? Comunque fosse, silenzi conniventi protessero il segreto negli anfratti dei palazzi di famiglia, abituati a tenersi nascoste molte cose. Si sarebbero tenuta nascosta anche questa, come tante altre, se non fosse rimasta emersa una terribile traccia, una sorta di automutilazione della bambina oggetto di tanta violenza, che si fece sorda e muta ai rumori del mondo.
Stupro è una parola che fa male, quasi uno sputo, una parola-pietra che si scaglia contro la persona; incarna una violenza, un’onta, una turpitudine, forse da avvicinare al verbo latino “stupere” e a “stupore”.
Il dizionario Devoto-Oli definisce stupore “senso di grande meraviglia, incredulità, disorientamento provocato da qualcosa di inatteso, stordimento, intorpidimento, arresto della motilità volontaria, associato a torpore dell’attività ideativa o a distacco dalla realtà esterna.” Quasi un rallentamento, un indebolimento dell’attività psichica, che non vuol essere per non dover sembrare, che non vuole sentire e parlare perché non vorrebbe aver sentito quell’affronto.
Stupro che provoca sturbo, quindi, scompiglio, sconvolgimento, mancamento della persona traumatizzata. E’ come se volesse exturbare, scacciare da sé il ricordo del trauma costruendo una barriera fra sé e il mondo dove sta quel qualcuno che l’ha stuprata e sturbata.
Così diventa mancamentata, mutola, oggetto di pietismo e di scherno.
Si definisce muta una persona incapace di usare il linguaggio locutorio, spesso si usa in espressioni che indicano, direttamente o allusivamente, l’assenza della parola (scena muta, cinema muto), si suole dire “star muto come un pesce” proprio in espressioni di connivenza. Tra le implicazioni più comuni c’è anche quella di una profonda desolazione o commozione (un muto dolore) o quella della segretezza (agire alla muta).
Il mutismo di Marianna, quindi, è dovuto a un trauma che diventa muto, segreto, nascosto, e talmente vergognoso da ammutolire.
Perché lei è stata mutilata, privata di qualcosa che ne compromette l’integrità, e quindi ammutolita, resa muta da un evento traumatico. Così come gli altri che sapevano sono ammutoliti dall’entità della vergogna che il suo diffondersi avrebbe arrecato all’intera famiglia, dalla forza della connivenza ormai radicatasi attraverso gli anni nella cultura maschile.
Già nelle metamorfosi di Ovidio troviamo Procris subito muta dolore fuit. Anche per lei è il dolore così forte ad ammutolire.
Cicerone nel De oratore definisce le arti figurative mutae artes, ma in questo caso la definizione sarebbe da discutere e discuterla ci porterebbe troppo lontano.
Insomma l’onta che subisce Marianna provoca due mutismi: quello della bambina, dovuto al trauma subito, per cui sceglie di immergersi nel più totale silenzio; quello degli uomini di casa, volto a salvaguardare l’onore della famiglia, per cui si sceglie di proteggere il mutilatore e di condannare la mutilata. Si instaura così una vergognosa complicità, una vile difesa di uno status consolidato maschile, segno tangibile che si è sempre e comunque contro le donne, in quella come in tante altre case.
E così (zac!), è come se l’onta le avesse tagliato la lingua, è come se Marianna con il mutismo si fosse costruita una protezione dall’esterno, ma questa protezione favorisce il maturare di un’interiorità sempre più profonda. Sinonimo di muto è concentrato, avviene infatti un progressivo spostamento del baricentro dell’individuo dall’esterno all’interno, quasi a raccogliere tutte le forze concentrandole nel profondo dell’intimo. Queste forze sbocceranno piano piano in un taccuino che diventa mezzo di comunicazione con gli altri; e la parola scritta si trasforma in ponte che unisce distanze, strada che fa intravvedere nuove mete.
Marianna intraprende un viaggio avventuroso alla scoperta del mondo, un viaggio capace di liberarla dai tenaci pregiudizi che avevano tentato di legarla, e la scrittura è il veicolo che la guida e l’accompagna.
La “mutola”, la “boccuzza di pesce” si fa “mezza volpe e mezza sirena”, “una voce senza voce a cui il Signore ha fatto dono di entrare nella testa degli altri”, “una donna che conosce Sant’Agostino e Socrate, Saint-Simone e Pascal”, “una donna che non è di tutti i giorni”.
Non si confonde con le altre donne costrette a lasciare l’intelligenza a impigrire, oppure a inventare astuzie sempre nuove, per non lasciarsi schiacciare dall’onnipotenza maschile. “Ma che siamo noi femmine su questa terra? Carne perché gli uomini se la mangino!?” grida la fedele Innocenza.
Lei “signora dalla gola di pietra”, “voce senza voce”, trova la sua voce nella scrittura.
La scrittura si fa veicolo di vita, costruttrice di relazioni e formatrice d’identità: crea in lei una vera donna.
Perché la scrittura è strumento di analisi, favorisce l’introspezione e struttura l’autoanalisi, elabora e intaglia, compone rapporti profondi, porta il dove in collegamento con molti altrove. Promuove e incoraggia un progressivo spostarsi dal sensibile all’intelligibile, alla ricerca del senso del mondo e delle cose.
La scrittura permette la realizzazione sensibile dell’idea intelligibile, favorisce il superamento di quel senso di ovvietà che governa la comunicazione utilitaristica quotidiana. Smuove, disincaglia e scompone il pensare e il sentire abituali, combatte il rischio di assuefazione all’ingiustizia, alla bruttezza e all’insensibilità.
Marianna si immerge sempre più nel gusto estetico del bello, attraverso la passione per la lettura e per la cultura, fino a raggiungere il fascino di “pensare il pensiero secondo i suggerimenti del Signor Hume”. Mentre il “Signor marito zio” è “abitato da stracci di pensieri che sgusciano come spifferi d’aria da quella testa sbiancata e priva di saggezza”, si immerge nella “pratica del pensiero”, così inusuale per le donne di quel tempo e di quella società, tenute in “uno stato di ignoranza gallinacea”.
Marianna supera però il rischio affascinante di “pensare il pensiero”, il pericolo seducente di appaesarsi nel regno del puro pensiero; non si separa dal mondo, ma sceglie di immergersi sempre di più. Sarà l’amore, succo vitale del mondo che fino ad ora le era stato negato, a farle ritrovare una parte del proprio corpo che credeva perduta per sempre; ma non si farà schiava d’amore, lascerà “quell’isola dove regna l’ingiustizia più assennata, tanto da risultare naturale”, taglierà i lacci dell’amore capaci di creare nuove prigionie, supererà i confini di un’identità femminile pur conquistata con fatica. La scelta sarà quella di proiettarsi, attraverso un mito del maschile, il viaggio, verso un mondo variegato e complesso, fluido e mutevole, ma creativo “alla ricerca di quel qualcosa che appartiene al mondo della saggezza e della contemplazione”, “mentre il passato era una coda che aveva raggomitolato sotto le gonne… il futuro era una nebulosa dentro a cui si intravvedevano luci di giostra”.
“Quando sei triste chiudi gli occhi e vola via” le aveva scritto la nonna, e allora Marianna diventa “la fanciulla che imparò a volare” e questo nuovo imparare le fa scrivere: “sento una parte della mia vita che comincia adesso”.
Ma il finale del libro sconcerta e sturba: “la risposta che riceve è ancora una domanda. Ed è muta”.
È vero il mutismo non si può vincere con la presunzione delle risposte, ma si può tentare con l’intelligenza delle domande.
Artemisia
Violare regole e tradizioni produce arte di tensione che di per se stessa è forza emancipatrice, produttività creatrice, nuova possibilità di percepire il mondo diversamente da come si presenta: stemperamento e rovesciamento del brutto nel suo contrario.
Artemisia Gentileschi, straordinaria pittrice del è stata narrata da Anna Banti così come Marianna Ucria da Dacia Maraini, e nella narrazione è diventata una figura simbolica, rappresentativa del percorso che la donna deve intraprendere per la sua liberazione. Come Marianna ha trovato nella scrittura la sua strada per comunicare con il mondo, così Artemisia ha scelto la strada della pittura e ambedue sono state sublimate dalla narrazione della loro vita da parte di due scrittrici. Ambedue sono state traumatizzate da uno stupro in giovane età e le loro vite si sono improntate alla ricerca di una sorta di risarcimento al male di essere, a cui sono state costrette dal flusso di una storia tragica e conflittuale.
Le accomuna il proposito di non fuggire dalla realtà, ma di cercare di potenziarla, così la natura perturbante di quel che è accaduto è come sublimata dalla cultura e dall’arte, diventa fattore di rigenerazione capace di tradursi in forme di bellezza.
Il dispiegarsi delle loro vite è sostenuto da una strenua ricerca del germe insostituibile della bellezza e delle sue forme, quella bellezza che in tutte le epoche sorprende e si rinnova, sfuggendo a qualsiasi definizione univoca e conclusiva.
Artemisia raffigura indomite eroine (Giuditta, Salomè, Dalila, Giale, Cleopatra e Betsabea) tutte segnate dalla violenza della vita e della storia, rappresentando continuamente se stessa, a volte con una forte carica di idealizzazione, a volte con prorompente sensualità.
Si può leggere nella crescita della sua pittura una crescita della propria identità: le esperienze traumatiche subite in giovane età prima vengono fortemente proiettate sulla tela, poi progressivamente trasformate dall’interiorità.
Artemisia diventa campione del femminismo, figura emblematica, esempio di “riconciliazione con la propria natura femminile, che ha elaborato il contraddittorio rapporto col maschile”. (Monica Toraldo di Francia)
Marianna e Artemisia rompono un concetto di virtù che coincide con l’adeguamento a modelli e regole del mondo in cui vivono; ambedue intraprendono un percorso, di emancipazione e di autorealizzazione pur segnato da contraddizioni, ambivalenze e provocazioni, verso la riconciliazione con la propria natura femminile, che ha elaborato il difficile e contraddittorio rapporto con il maschile. Per ambedue si può parlare di un percorso di individualità integrata.
Ambedue sono ‘mancanti’ di madre, figura che nel mito viene sempre in aiuto: in Artemisia, Tuzia, la figura femminile più vicina, si rivela complice del Tassi. In Marianna si fa, forse involontariamente, complice degli uomini di casa.
Percorso
Ambedue mettono le ali ai piedi e superano confini attraverso la cultura e l’arte.
Diventano simboli di come l’arte sia allegoria della libertà, scoperta di una nuova e più feconda possibilità di vita, l’arte che dà dignità e spinge l’uomo “a riveder le stelle”.
È come se Artemisia ci chiamasse a leggere nelle sue opere – opere aperte, come tutte le opere – le molte facce del femminismo contemporaneo e ci invitasse a riconoscerla nostra contemporanea.
E’ come se Marianna, dal quadro che la rappresenta, con l’esibizione del suo taccuino (simbolo della scrittura e quindi della narrazione) chiedesse a Dacia che la guarda con curiosità la narrazione della sua storia, come se rivendicasse la dignità di un sé narrabile.
Perché i morti non sono altro che il racconto della loro storia.
Morta Euridice Orfeo cerca consolazione nella sua arte e il suo canto si diffonde insieme alla memoria di lei e sarà ripetuto di generazione in generazione, divenendo immortale, anche oltre il tempo di vita concesso ad Orfeo.
Scrittura che si fa letteratura, quindi arte.
È un crocevia di significati carico di emozioni.
Parla il linguaggio incantatore degli affetti dei sentimenti.
Ha potere di fascinazione di suscitare incanti.
Così alla fine non è solo l’arte ad essere estetizzata, ma la vita stessa. Narrazione e vita si identificano, come per Sheherazade, Marianna nasce e vive nella scrittura sua e nella narrazione di Dacia Maraini.